| IL
FOTONE La natura della luce è stata per
secoli motivo di studio e di speculazione filosofica da parte degli scienziati delle varie
epoche. C’era qualcuno, come Newton, che sosteneva che la
luce fosse composta di minuscole particelle o corpuscoli, altri che fosse un’onda.
Nel secolo scorso, poi, con l’affinarsi delle tecniche sperimentali e con la maggiore
conoscenza delle leggi che regolano il mondo delle onde (come l'interferenza e la
diffrazione), si arrivò a concludere che la luce è un’onda che si propaga nello
spazio.
Oggi sappiamo che questa è un’onda elettromagnetica come lo sono, ad esempio, le
onde radio e le microonde.

Verso la fine del secolo scorso, nuovi e più precisi
esperimenti evidenziarono proprietà della radiazione elettromagnetica che non potevano
essere spiegate pensandola come un’onda. Agli inizi di questo secolo il fisico Max Planck concluse che, affinché alcuni risultati sperimentali
potessero essere spiegati in maniera corretta, era necessario che l’effetto della
radiazione elettomagnetica fosse quantizzato. Era cioè necessario trattare gli effetti
della radiazione elettromagnetica e quindi dello scambio di energia,
come se fossero portati da delle particelle.
Era l’inizio di una nuova era della fisica: quel giorno cominciava la fisica dei
"quanti", uno dei cardini della fisica moderna.
Pochi anni più tardi Albert
Einstein, studiando alcuni risultati sperimentali apparentemente inspiegabili legati
all’effetto fotoelettrico, arrivò ad una soluzione ancora più radicale di quella
proposta da Planck: non erano gli effetti della radiazione elettromagnetica a dover essere
quantizzati, ma la radiazione stessa.
Questi "quanti di luce" di cui è composta la radiazione elettromagnetica sono
detti fotoni e sono particelle a massa nulla. L’energia di un fotone è
proporzionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica a cui appartiene, secondo
la formula:
E = hu
dove "h" è una costante fondamentale della
fisica: la costante di Planck.
Il considerare la luce composta di corpuscoli come
volevano alcuni fisici dei secoli scorsi ha in realtà origini più strettamente
filosofiche ed in ogni caso per nulla simili a quelle addotte da Einstein.
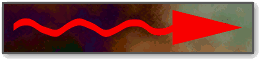
Negli anni successivi molti fenomeni della fisica
all’apparenza oscuri furono spiegati ricorrendo alla quantizzazione della radiazione
(o campo) elettromagnetica in fotoni. Ricordiamo, ad esempio,
l’effetto Compton, dal nome del fisico che per primo
spiegò i risultati sperimentali ottenuti utilizzando la quantizzazione del campo
elettromagnetico.
Queste continue vittorie della "teoria dei quanti" ponevano però un problema di
fondo: la radiazione elettromagnetica, e quindi la luce, è un’onda od un flusso di
particelle?
La maggior parte dei fenomeni, infatti, può essere spiegata sia in termini ondulatori che
corpuscolari, ma esistono fenomeni che possono essere spiegati con uno soltanto di tali
schemi. Queste problematiche sulle proprietà della luce vanno sotto il nome di "dualismo
onda-corpuscolare della luce" e vengono superate con il "principio di
complementarità" che stabilisce la duplice natura della radiazione
elettromagnetica.
Il comportamento particellare od ondulatorio è determinato da ciò che si vuole
osservare, e per quanto questo possa sembrare paradossale, corrisponde a ciò che
realmente si osserva.
Nella "teoria relativistica dei campi quantizzati", che descrive il
comportamento delle particelle, il concetto di onda viene definitivamente abbandonato ed i
fotoni diventano il mezzo con cui la radiazione elettromagnetica si propaga.
In quegli anni i fisici stavano trattando un argomento
incredibilmente nuovo e vasto senza neanche immaginarlo, e per spiegare alcuni effetti
misteriosi finirono spesso per fare affermazioni, ripensando alle quali, in futuro,
avrebbero probabilmente sorriso.
Un giovane fisico francese, Louise De Broglie, scrisse nella sua
tesi di laurea che tutte le particelle sono in realtà delle onde. Pochi, ovviamente, gli
avevano dato ascolto in quel momento.
Alcuni anni dopo, però, un esperimento condotto da Davisson e Germer fornì risultati
spiegabili solo con l’intuizione di De Broglie; inoltre in quegli anni Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg,
nel porre le premesse della "meccanica quantistica", inserirono
l’idea di De Broglie tra i concetti fondamentali.
Per quanto riguarda le particelle, nella meccanica
quantistica il concetto di oggetto puntiforme è scomparso a favore del concetto di onda.
Come conciliare tutto questo con le evidenze sperimentali dell’esistenza delle
particelle?
Se una particella non è un oggetto puntiforme, come facciamo a dire dove sta e con quale velocità viaggia, dato
che un’onda non sta in un posto preciso?
Per uscire da questo paradosso Heisenberg arrivò a formulare il "principio di
indeterminazione". Esso afferma che possiamo ancora trattare le particelle come
punti materiali, a meno che non cerchiamo di sapere la loro posizione
e contemporaneamente la loro velocità con una precisione
infinita.
Nel mondo macroscopico tutto è composto da particelle, in
quanto la precisione delle misure è molto minore dei limiti imposti dal principio di
Heisenberg.
La meccanica quantistica si basa su concetti che sono molto diversi da quelli del senso
comune; a settant’anni di distanza dalla sua nascita, chiunque si avvicini ad essa
trova all’inizio non pochi problemi a digerirla. Quando nacque, molti fisici la
contestarono fortemente perchè non ne condividevano le basi così estranee a quelle
sviluppate per la fisica classica.
L’idea che di una particella non si potessero conoscere contemporaneamente posizione
e velocità con precisione infinita, e quindi non si potesse ricavare una precisa legge del moto, dispiaceva persino ad Einstein, che affermava di
non credere che "Dio gioca a dadi".
Ma, per fortuna, le cose che funzionano sono destinate a restare e la meccanica
quantistica è oggi un branca della fisica in continua evoluzione. |
